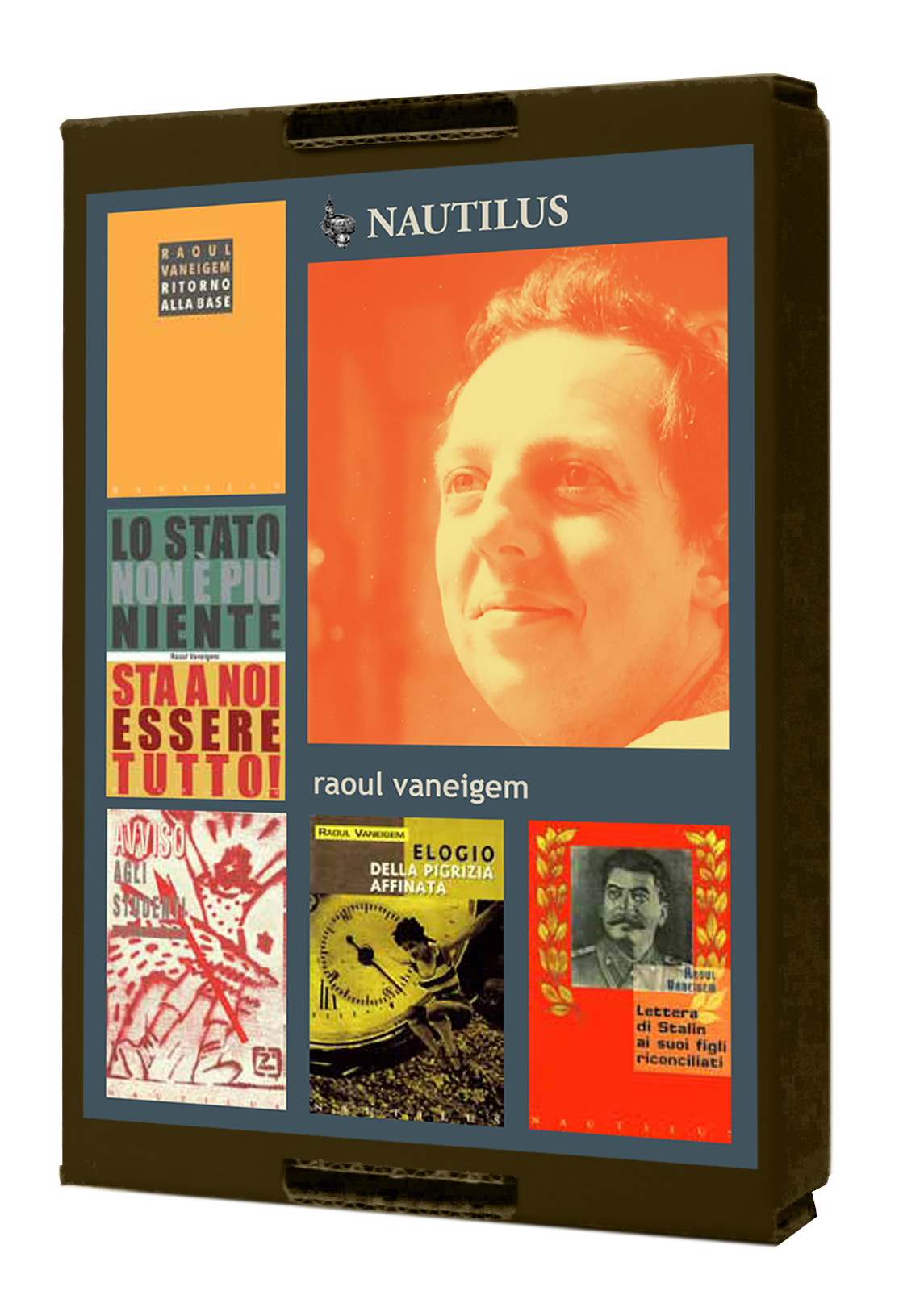CARLO DEL BUONO: allucinogeni, psichedelici, enteogeni, come li chiamiamo?
In questo mio intervento mi riferisco principalmente alle sostanze psicoattive che vengono definite psicodislettiche in quanto inducenti modificazioni qualitative dell’umore (aggiungerei anche “e della coscienza”) e più specificatamente allucinogene data la forte componente delle modificazioni percettive che alle prime si aggiungono.
Insomma soprattutto LSD mescalina e psilocibina, per intenderci, sorvolando su tutta una serie di sostanze, sintetiche e non, con effetti simili.
C’è tutto un proliferare di nomi (psicotomimetici, psichedelici, enteogeni, ecc.) e credo che in larga parte questo dipenda dal fatto che con le sostanze interagiscono in modo decisivo nel determinare il tipo di esperienza il SET (caratteristiche di fondo e condizioni attuali dello sperimentatore – vedi figure 2 e 3) e il SETTING (ambiente in cui si sperimenta). Questo apparve chiaro fin dai primi studi, anche se la sua ovvietà è stata continuamente e abbondantemente misconosciuta, e ci obbliga direi all’esigenza di considerare le sinergie che concorrono a determinare non solo una specifica esperienza ma anche un percorso di crescita. Tornerò sul tema delle sinergie; ora desidero solo sottolineare l’importanza del prendersi cura di sé e della ricerca di un ambiente favorevole – e ciò il più possibile anche prima e dopo un’esperienza, oltre che durante; troppo diffusa è stata l’abitudine di delegare in toto alla sostanza il senso di quello che si andava facendo; il che ha coinciso col non trovare un senso, e da ciò ha avuto probabilmente origine l’uso reiterato (potremmo veramente dire il consumo) che ha poi come sbocco, se va bene, il suo opposto, il totale non-uso.
Ma veniamo a un primo nome che si è voluto attribuire alle sostanze in questione: psicotomimetici (che inducono uno stato psicotico). È il nome che, se vuole indicare la generalità delle esperienze, richiede un massimo grado di sprovvedutezza o di mala fede. Sicuramente se l’io è particolarmente fragile e/o l’ambiente particolarmente sfavorevole (vedi figura 4) lo sbocco può essere psicotico (e un terreno di psicosi latente può provocare una vera crisi che si protragga nel tempo ben oltre la durata standard degli effetti della sostanza); ma c’è chi ha voluto ritenere che tale sbocco sia quello che generalmente si ottiene, senza considerare le circostanze di SET e SETTING concretamente presenti. Si è arrivati a “lavori” di psichiatri anche noti che hanno preteso di studiare l’LSD in ambiente “sperimentale”, “oggettivo”, somministrando la sostanza in un ambulatorio, col “soggetto” seduto su una sedia di ferro smaltato e loro silenziosi (per non interferire!) ad osservare, in camice bianco, le “reazioni”; le quali ovviamente sono state di insofferenza e sgradevolezza e sono state registrate come gli “effetti paranoici” dell’LSD e portate come dati probanti di una “ricerca scientifica”! È stato come colpire in testa con una spranga qualcuno e poi dirgli con fare professorale e clinico: “Lei soffre di un trauma cranico”.
Tiro perciò una riga sul termine psicotomimetici e passo a considerane un altro, che va per la maggiore: allucinogeni (che generano allucinazioni); ci si riferisce a modifiche delle percezioni, comprendendo anche quelle di tipo eidetico (vivide immagini a occhi chiusi; potremmo usare, perché no?, anche il termine eidetici …). La parola “allucinazione” dà però alla modifica una connotazione negativa, di alterazione riguardo a uno stato implicitamente ritenuto “oggettivo”, “reale”. Questo però contraddice due possibilità.
La prima, che le immagini a occhi chiusi siano particolarmente significative, costituendo quella “coda di pavone” in cui sono incastonate le gemme che Huxley (1) ritiene costituiscano gli antipodi della mente, gli Altri Mondi. Per questo grande scrittore la visione delle gemme costituisce un primo fondamentale livello che precede quello più significativo del manifestarsi di una luce indifferenziata, al di là delle forme e dei colori che vengono trascesi se si evita attaccamento o rifiuto nei loro confronti. Viene in mente la Cintura di Diamante del Mandala che Tucci (2) ci dice formata prevalentemente di lapislazzuli e che è la prima realtà che incontriamo subito dopo la periferia della Cintura di Fuoco. La Cintura di Diamante è perciò all’inizio della costruzione del Mandala, ma ha già in sé una grande forza anticipatrice che prefigura i livelli supremi della coscienza.
La seconda, che a occhi (e altri sensi) aperti si possano “aprire le porte della percezione”, creando perciò un contatto più profondo con una realtà che lo stato ordinario di coscienza ha appiattito. Non penso che tale favorevole esito sia meccanicamente “garantito” dalle sostanze in questione. C’è a mio avviso la necessità che il SET sia predisposto, cioè capace di una innocente attenzione, ben diversa dal controllo e dalla distrazione, che eviti di proiettare un disordine e un’incongruenza interni sulla ricchezza di stimoli e di dati che bussano alla porta; in caso contrario si apre la via a vere e proprie allucinazioni.
Ancor più delicato è il discorso sul termine che ancora va per la maggiore: psichedelici (“che rivelano la psiche” – in senso più ampio “che dilatano la coscienza”).
In effetti la parola psiche si confà bene alla sede di tutta una serie di modifiche che certe sostanze possono provocare; da quelle del livello immaginativo a quelle del livello analitico e simbolico, utilizzando lo schema di Houston e Masters (vedi figura 1). Ma se la dilatazione della coscienza può essere portata fino alle ultime conseguenze (e in fondo è di un termine che comprenda questa possibilità che io sono alla ricerca), allora sorge un dubbio: che la psiche (e il suo correlato somatico, il cervello) non siano più termini adeguati in quanto, rispetto alle potenzialità della coscienza essi potrebbero esercitare, come ritiene fra gli altri Bergson, una funzione di “valvola riduttiva”, “che integra alla realtà ordinaria, anziché essere la realtà primaria della coscienza stessa. Nell’ambito della suddivisione di Houston e Masters è dubbio che sia la psiche la sede del livello integrale, che sia insomma accettabile l’identificazione fra psiche e coscienza.
Forse condividendo questa obiezione, o quanto meno per specificare meglio certe potenzialità, si è coniato il termine enteogeni (“che generano il divino che è in noi”). (Tralascio di considerare per esteso il termine misticomimetici, poco utilizzabile quanto meno per la sua ridondanza e poi perché, a parte la limitante definizione di “mistico” – Guenon ha scritto un libro per differenziare l’esperienza mistica da quella iniziatica (3) – la parola “mimetico” dà un’idea di una parodia della “vera” esperienza mistica, che solo in altri modi “naturali” sarebbe raggiungibile, il che apre un discorso cui preferisco accennare più avanti).
Enteogeni dunque. Non mi convince neanche questo.
C’è intanto il suffisso “geni”: dato che ci si riferisce a stati superiori, divini appunto, di coscienza, non mi sembra appropriato, verificato che tali dimensioni sono preesistenti a quelle ordinarie e perciò, più che essere “generati”, possono essere “rivelati” (suffisso “delici”) o “resi manifesti” (suffisso “fanici”).
Ma è soprattutto il termine “divino” che va considerato. Ricordo alcune importanti riflessioni apparse sull’editoriale di NAUTILUS che presentava il numero 2 di “ALTROVE”; si riproponeva la differenziazione guenoniana fra via iniziatica e via mistica, considerando la seconda come una alienante abdicazione alla propria autonomia.
Il buddismo stesso (e non è poco) evita accuratamente di nominare Dio e il termine “divino”; c’è un’ultima realtà che è il “vuoto”, mentre il “divino” è una realtà non ultima perché ancora “oggettiva” e riferendosi a lei con richieste e riti si corre il rischio di impedire la piena espansione della consapevolezza, cioè il fatto squisitamente individuale del risveglio (che poi va diffuso e condiviso, tramite il voto del bodhisattva che si reincarna fino a che l’ultimo essere vivente si è illuminato). Si tratta di una posizione che rinuncia a considerare il Dio immanente (l’Isvara induista) per accogliere solo l’ipotesi del Dio trascendente; che in effetti in tutte le tradizioni esoteriche non ha nome e può essere definito solo per negazione (anche per gli Indiani d’America, oltre il Grande Spirito, c’è il Grande Mistero).
Esiste sicuramente il problema di sapere se le sostanze di cui discutiamo (in certe situazioni privilegiate di SET e SETTING, meglio esprimere il più possibile quest’ovvio inciso) permettano o no di giungere alle ultime verità. Secondo alcuni studiosi (4), nella tradizione cabalistica l’uso degli psichedelici può essere d’aiuto fino a un limite (corrispondente all’apertura del 6° centro) e non oltre il tentativo di aprire il 7° esporrebbe a gravi rischi. Ram Dass (5) è dell’avviso che quando la consapevolezza si apre con l’aiuto di sostanze chimiche ci si trova a valutare livelli molto delicati e sottili. Non si può però escludere di poter spingersi verso esperienze estremamente rarefatte e informali, a cui poco si confà il termine “divino”; il resoconto di Nesher “Sull’isola”, apparso sul n° 2 di Eleusis, mi sembra possa esserne un esempio.
Rispetto a tutta la questione una chiave interpretativa che a mio avviso va valorizzata è quella che, nel considerare la componente SET, tiene conto della tipologia psicologica ipotizzata da Jung (6). Per il tipo estroverso è irresistibile la tendenza a voler concretizzare la verità in un dato oggettivo che dà spiegazione e senso alle cose; se ci si riferisce a tutte le cose, al “mondo”, chi dà senso è allora un Dio creatore a cui ri-legarsi: è consono a chi vive questa istanza la parola stessa “religione”. Per il tipo introverso non è tanto importante che ci sia una verità quanto che lui stesso ne sia consapevole; perciò è alla massima espansione della propria consapevolezza che egli aspira.
Per l’estroverso è essenziale cambiare il mondo (in accordo col volere di Dio, se l’istanza è anche religiosa), per l’introverso è essenziale decondizionarsi dal mondo, non dipendere dai limiti che il mondo impone. Mi sembra questa la radice che differenzia cristianesimo e buddhismo, anche se è da tener presente che compito del tipo estroverso è, nel realizzare se stesso, di introflettersi (il che permette a molti mistici cristiani di raggiungere alte vette di introspezione estatica – vedi San Giovanni della Croce), mentre compito del tipo introverso è, nella misura maggiore possibile, di estroflettersi (e allora il bodhisatva che giunge alle soglie del decondizionamento supremo, al nirvana, torna indietro compassionevole per aiutare tutti gli altri esseri a raggiungere il medesimo scopo).
Concludendo, enteogeni, oltre a un suffisso che appare improprio, ha una prima parte che soffre di parzialità. Un termine più neutro rispetto alla tipologia psicologica dello sperimentatore e comprensivo di varie possibilità conoscitive intermedie potrebbe essere vidia (dal sanscrito: conoscenza, conoscenza della realtà – contrapposta ad avidia, ignoranza) seguito da fanico (che mostra, manifesta) o da delico (che rivela).
Anche per evitare l’accostamento del sanscrito al greco, si potrebbe della prima lingua usare (tralasciando alezeia, verità – da cui alezeiadelici, un po’ lunghetto) il termine keneov, spazio vuoto, il vuoto, da cui keneodelici o keneofanici, o anche keneogeni se ci si riferisce al basilare effetto dell’ondata chimica che poi permette di giungere a vari livelli, fra cui quello keneofanico, quando ci si rende aperti alla percezione di uno spazio vuoto onnipervadente e non generato. (vedi figura 1).
Più spazio: dilatazione della coscienza (apertura di sinapsi, nuovi circuiti disponibili) – più consapevolezza, spostamento di energia dall’identificazine coi contenuti (pensieri, emozioni, percezioni) al contatto col contenitore accogliente di una consapevolezza che non detta condizioni. Misuriamo la nostra disponibilità a uscire dallo stato ordinario – la nostra disponibilità a una fase in cui non c’è niente da fare, solo semplicemente accogliere. Allora contenuti sacrificati possono affacciarsi e chiarificarsi, con la capacità di cogliere collegamenti, di farne di nuovi. Però è anche possibile aprirsi all’apertura stessa del contenitore e scoprire che la consapevolezza in sé è una realtà, è la realtà, pura coscienza, che trascende le capacità cerebrali. Entrando in questa dimensione lo stato modificato è di tale pregnanza che può facilmente spingerci a un errore molto comprensibile: quello di ritenere che quanto raggiunto sia lo stato transpersonale, mentre è possibile (e necessario, se la propria ricerca è esigente) una discriminazione di svariati livelli. A questo riguardo Tart ci presenta varie scale (7); di grande interesse ho trovato la descrizione degli stati di coscienza che il Buddha attraversò prima di giungere al Risveglio, nella prima parte del bel libro di Thich Nhat Hank (8); nella tradizione cristiana è San Giovanni della Croce a indicarci specifiche stazioni intermedie dell’ascesi estatica (9).
Ma è il momento di dire qualcosa sulle sinergie; parlare di vari nomi ha poco senso se non ci si spinge quanto meno a impostare un discorso sulle condizioni concomitanti che spingono a far sì che un nome sia più appropriato di un altro per definire un’esperienza.
Ho già premesso genericamente l’esigenza del prendersi cura di sé.
Come è attrezzato il SET che approccia la sperimentazione?
Di che entità è la zavorra nevrotica che si porta dietro?
È il suo io sufficientemente forte ed elastico? (a tale riguardo una buona e, in lingua italiana, purtroppo abbastanza isolata elaborazione rimane quella apparsa in Psichiatria dinamica) (10).
Quali pratiche mentali che lo abbiano allenato all’accoglienza consapevole ha coltivato?
Quali concezioni generali è giunto a ipotizzare?
Cosa sa?
Cosa sa di non sapere?
E ancora: come si alimenta in genere e in particolare in prossimità dell’esperienza?
Vengono fuori già tre fattori dei quali è difficile pensare di potersi disinteressare totalmente: psicoterapia, meditazione, alimentazione. E ovviamente non sono gli unici possibili.
Nelle sinergie sta anche la chiave per affrontare proficuamente non solo l’esperienza, ma anche e soprattutto ciò che segue l’esperienza; vale a dire la sua integrazione.
Scrivevo nell’articolo su Percorsi psichedelici già citato che “non esiste un’esperienza psichedelica, ma esiste ciò che noi integriamo di essa”. Era la sintesi di ciò che negli anni ‘60 ero arrivato a ritenere, anche grazie all’insegnamento di Emilio Servadio (11). Di tempo ne è passato, ma ho avuto solo conferme.
Se l’io si destruttura e si attinge a una realtà transpersonale c’è il problema di rientrare in contatto col quotidiano, a effetti chimici finiti, “come se l’esperienza fosse avvenuta”, anziché “come se non fosse avvenuta”. Nel quotidiano l’io si re-identifica, ma è possibile mantenere l’eventuale apertura keneodelica – e uno strumento sinergico fondamentale può rivelarsi un tipo appropriato di meditazione – o continuare il lavoro iniziato nella dimensione psichedelica che ha fatto emergere contenuti e aspetti che ora vanno saldati alla coscienza – tramite riascolto di nastri, introspezione, confronto, sedute psicoterapeutiche, ecc.
Desidero chiarire che parlando di sinergie privilegio una prassi che per lo più non mescola varie componenti nella contemporaneità di un’esperienza. Sono dell’idea ad esempio che convenga attribuire alla psicoterapia il compito indipendente di prendersi cura degli “arretrati”, mentre a meditazione e keneodelici spetta la ricerca degli stati modificati di coscienza e la creazione di contesti di tipo sacramentale.
Il segnale che si va nella direzione dell’integrazione in genere lo dà il fatto di prendersi tempo, molto tempo fra un’esperienza e l’altra. Certo, non possono fissarsi regole, ma l’uso reiterato è sempre un segnale sospetto di disinteresse all’integrazione; di voler andare con la mano pesante, dimostrando attaccamento nei confronti delle sostanze (non parliamo però, oltre che di assuefazione fisiologica, che è già esclusa in partenza, neppure di assuefazione psicologica, che non vuol dire pressoché nulla), nella direzione opposta alla consapevolezza, che accoglie anziché cercare di afferrare.
Penso ci si debba arrendere al paradosso che le cose ci sono veramente utili quando possiamo farne a meno; solo allora la mano ha la giusta presa, la spada non ci sfugge per eccesso di tensione o di mollezza e il processo di disidentificazione ci permette un gioco sinergico arioso e produttivo. Confortano questo orientamento le parole che Neem Karoli Baba (Maharaji, Maestro di Ram Dass) espresse alla domanda sull’opportunità di prendere LSD: “Se ti trovi in un posto tranquillo e sei solo e senti dentro di te una gran pace e la tua mente è rivolta a Dio, potrebbe essere utile”.
E veniamo alla necessità di prendersi cura del SETTING.
Ho accettato le ultime parole del sottotitolo, dato a questa conferenza sul “Come li chiamiamo?”, che suona “Quali nomi e quali sinergie per i sacramenti del duemila”, per due motivi: che si concedono mille anni di tempo (se va proprio male) a queste sostanze per, diciamo così, affermarsi come sacramenti; e poi per il fatto che esistono già oggi alcuni esempi di comunità in cui l’uso legale di sostanze vegetali è chiaramente enteogenico (io direi enteodelico)-sacramentale. Riguardo a una di esse, una comunità del Gabon, abbiamo la fortuna di poter conoscere i resoconti (12) di un italiano, Giorgio Samorini, uno dei pochissimi che in quella zona è stato iniziato alla religione Buiti tramite una cerimonia centrata sull’assunzione dell’iboga.
Perciò l’uso sacramentale non è solo un lontano ricordo, e in più ci concediamo vari secoli per poterlo fare riconoscere ed espandere.
Ma, e sottolineo ma, nel nostro contesto occidentale quali sono i SETTING consoni all’uso sacramentale? Quali religioni coltivano ancora l’obbiettivo, o almeno la speranza, di promuovere un’esperienza diretta del divino?
Chi sa cosa è un sacramento e come lo si somministra?
E, ammesso che qualcuno sappia, è possibile sviluppare una tale prospettiva lavorando nella clandestinità?
Contro il proibizionismo si sollevano giustificatissime critiche, ma non ci sono ancora delle idee chiare su cosa debba significare e attraverso quali tappe raggiungere la liberalizzazione. In un recente incontro della SISSC ipotizzavo una decisione fantapolitica che concedesse ai medici la possibilità di prescrivere qualsiasi tipo di sostanze sintetiche. Mi si è obbiettato l’ovvio: che la classe medica è impreparata, chiusa, non degna di un simile potere.
Eppure ben altri compromessi si dovranno accettare per aprire spiragli nella soffocante situazione attuale; e l’area del compromesso è concretamente proprio quella della terapia e della ricerca in campo medico e psicoterapeutico. Dare la possibilità a quella percentuale di medici aperti di prescrivere keneodelici alle persone ritenute preparate (e ai gruppi che tale persone potrebbero formare) sarebbe un atto che personalmente non riesco a evitare di considerare rivoluzionario; infatti esula attualmente dall’ambito del possibile.
Il problema del SETTING sacramentale apre poi il rilevante problema del modellaggio dell’esperienza, della possibilità che esso sia rigido o flessibile, della possibilità che esso apra orizzonti angusti o spaziosi, eccetera – tutte cose su cui spero che nei prossimi secoli potremo iniziare a discutere seriamente.
Un’ultima cosa prima di concludere. Questa cavalcata attraverso i nomi forse ha un traguardo, che è quello di uscire dai nomi, protesi sinergicamente a spingere lo sguardo sulla realtà che viene dopo, o meglio prima, dei nomi.
C’è un primo compito, che è andare oltre l’attribuzione meramente convenzionale e trovare per le cose i nomi che siano veramente appropriati, avendo essi in sé la qualità, l’essenza delle cose cui si riferiscono (e in ciò è forse indispensabile il ricorso alle lingue sacre).
E poi ce n’è un secondo: di andare al di là dei nomi, di attingere alla capacità di non dare nomi alle cose, di non perdersi nelle differenziazioni e nella parzialità di oggetti imbalsamati anziché percepiti nel flusso che li permea.
Allora, se le nostre sostanze possono aiutarci a giungere fino a questo punto, il nome che potremmo attribuire loro deve indicare la capacità di aprire la coscienza oltre i nomi: iperonimi, dunque.